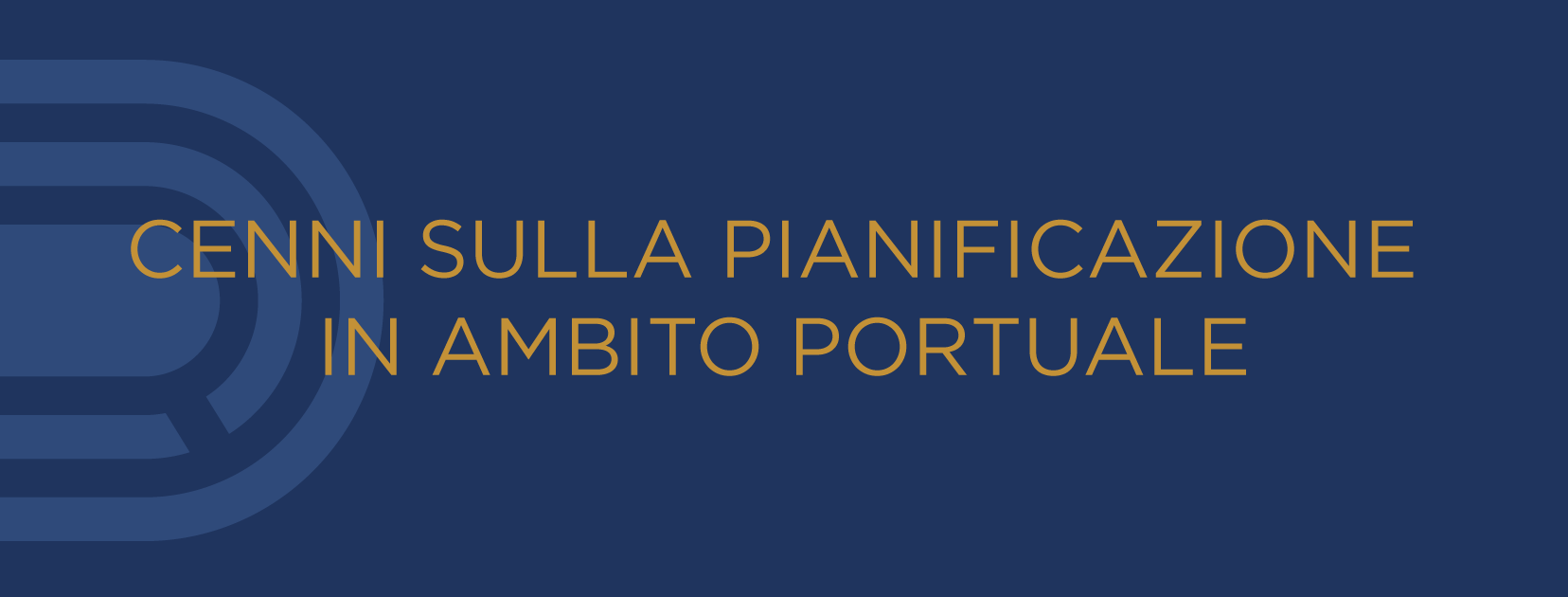A cura dell’avv. Giuseppe Delle Foglie
Sommario: 1. Premessa. – 2. La pianificazione in ambito portuale nella legislazione italiana. Il Piano regolatore di Sistema portuale. – 3. Le Varianti-stralcio e gli Adeguamenti Tecnico-Funzionali (ATF). – 4. I Piani regolatori nei porti non facenti parte di un’Autorità di Sistema Portuale. – 5. Conclusioni.
1. È fatto notorio come nel corso degli ultimi decenni l’incremento delle attività economiche sulla zona costiera nonché sulle acque interne e, comunque, sul mare territoriale, abbia profondamente mutato l’approccio dell’uomo sull’utilizzo di tali risorse con ogni conseguente impatto sotto il profilo ambientale e paesaggistico oltre che economico e socio-culturale.
In tale mutato contesto, ove ai tradizionali usi pubblici del mare se ne sono affiancati di nuovi, si è avvertita l’esigenza di dedicare al corretto uso della costa e del mare la dovuta attenzione mediante l’adozione di strumenti legislativi tesi a contemperare i plurimi interessi, di rilevanza pubblicistica e non solo, esistenti sulla costa o, comunque, più in generale sulla “risorsa” mare.
La pianificazione, pertanto, assurge oggi a momento fondamentale per la programmazione di tutte le attività che possono essere esercitate nei porti (e, più in generale, sulla costa), specie in quelli ove coesistono le diverse funzioni (commerciali, industriali, turistiche o legate alle attività di pesca) come individuate dall’art. 4, co. 3, legge n. 84/1994 (c.d. “Legge Porti”).
Pianificare e programmare le attività di un porto, d’altronde, significa soprattutto prevederne il futuro. E prevedere il futuro di un porto vuol dire impattare sull’intero tessuto economico e sociale di un territorio.
2. La disciplina afferente la pianificazione portuale, allo stato, è regolamentata dall’art. 5, legge n. 84/1994 (c.d. “Legge Porti”).
In via preliminare deve riferirsi come l’art. 5, Legge Porti, nella sua attuale conformazione, appare profondamente diverso dalla sua versione originaria in quanto, sia con la novella di cui al d. lgs. n. 169/2016 sia il “Correttivo” di cui al d. lgs. 232/2017, sono state introdotte importanti novità tese a meglio dettagliare il procedimento di adozione ed approvazione dei Piani.
Tanto premesso può qui rilevarsi come, ad oggi, esistano due tipologie di piani:
- il piano regolatore di sistema portuale, proprio di quegli scali ricompresi nel perimetro di competenza delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP);
- il piano regolatore portuale per i restanti porti.
Il primo, in particolare, si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e, quindi, del singolo Piano regolatore del porto o dei porti facenti parte dell’Autorità.
Il DPSS, secondo quanto prescritto dalla “Legge Porti”, deve essere coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Secondo le prescrizioni della Legge n. 84/1994, inoltre, il DPSS:
- definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di Sistema Portuale;
- individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
- prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l’assetto territoriale del sistema, nonché per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies.
Quanto al sotteso iter procedimentale, qui può sinteticamente rilevarsi che il Documento di pianificazione strategica di sistema è adottato dal Comitato di gestione AdSP e approvato nei successivi sessanta giorni dalla Regione territorialmente competente (o dalle Regioni se il “Sistema Portuale” si estende oltre un unico territorio regionale) previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS).
Una volta approvato il DPSS, quindi, l’Autorità può procedere con la fase di adozione e approvazione del Piano Regolatore Portuale (o dei singoli Piani laddove siano presenti più porti all’interno di una AdSP) ove, a mente dell’art. 5, co. 1 sexies, L. n. 84/1994, da un lato, viene delimitato e disegnato “…l’ambito e l’assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie…” e, dall’altro, vengono individuate le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione di opere pubbliche.
Con il PRP, inoltre, vengono specificati gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo delineando anche l’assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
Quanto al procedimento amministrativo teso alla definizione dei Piani regolatori portuali ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle AdSP, anche in questo caso il Piano è adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con i comuni territorialmente interessati che si esprimono solo in ordine alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città, e successivamente trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici che rende parere entro novanta giorni dal ricevimento dell’atto.
Il PRP, poi, viene sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvato dalla Regione entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della detta VAS.
Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Laddove il Piano regolatore sia approvato, è consentito all’Autorità di Sistema Portuale, su impulso del Presidente o su richiesta della Regione e/o dei Comuni eventualmente interessati, di promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al PRP concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
Dette varianti-stralcio, secondo quanto prescritto dal comma 4-bis, sono sottoposte allo stesso procedimento previsto per l’approvazione del Piano regolatore portuale e, quindi, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (come disciplinata dall’art. 12, d. lgs. n. 152/2006).
Spetta alla Regione, poi, la definitiva approvazione delle varianti-stralcio.
Nell’ipotesi in cui l’AdSP ricada in più regioni, la variante-stralcio è approvata dalla Regione nel cui territorio è ubicato il porto e, comunque, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima AdSP.
Oltre alle varianti stralcio, l’art. 5, co. 5, legge n. 84/1994, ammette una particolare procedura per quelle modifiche al PRP che “…non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo…”.
Tali modifiche sono definite Adeguamenti tecnico-funzionali (ATF) del piano regolatore portuale e sono adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, anche in questo caso previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città.
Il procedimento, quindi, viene definito con l’acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si esprime entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di ATF. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente (silenzio assenso).
4. I porti rientranti nella categoria II, classe III (ovvero i porti regionali o interregionali), devono munirsi, per espressa previsione di legge (art. 5, co. 3, lege n. 84/1994), di un Piano regolatore portuale che, come nel caso degli scali ricompresi in una AdSP, delimita l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie nonché individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
V’è da dire, sul punto, che la stessa norma in esame prescrive che sono esclusi dalla pianificazione i porti di terza classe aventi funzione “turistica” e “da diporto” [art. 4, co. 3, lett. e), legge n. 84/1994].
Sotto il profilo procedimentale, invece, il PRP è adottato ed approvato dalla Regione territorialmente competente previa intesa con il comune o i comuni interessati.
Anche in tal caso i Piani regolatori dei porti sono sottoposti a procedura VAS e non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
5. In conclusione, non appare superfluo qualche cenno in ordine alla natura giuridica dei Piani Regolatori Portuali che, come noto, è stata spesso dibattuta specie in relazione agli strumenti “tradizionali” di governo del territorio.
Sul punto, anche all’esito della più recente elaborazione giurisprudenziale, si è osservato come, almeno sino alla pubblicazione della c.d. “Legge Ponte” (Legge n. 765/1967), le aree portuali (al pari di tutte le aree facenti parte del demanio marittimo) non fossero soggette alle prescrizioni del piano regolatore comunale.
A seguito della citata Legge Ponte, invece, furono affidate alle amministrazioni comunale le competenze pianificatorie relative alle aree portuali.
La successiva assunzione da parte delle Regioni del potere di approvazione dei PRP, previa loro adozione da parte dei Comuni, ha fatto sorgere l’esigenza di introdurre un nuovo dispositivo di composizione degli interessi statuali e locali, esigenza alla quale ha cercato di rispondere la legge n. 84 del 1994, attraverso la creazione di Piani Regolatori Portuali di nuovo conio.
Tale processo, in particolare, si è poi definito proprio con la citata Legge n. 84/1994 che, tra gli altri, ha istituito le (allora) Autorità Portuali (oggi Autorità di Sistema Portuale), con cui si è provveduto ad un generale riordino delle funzioni di regolazione dei servizi portuali nonché di quelle di programmazione e, appunto, di pianificazione.
In particolare, circa la natura dei Piani regolatori portuali, è stato affermato dal Consiglio di Stato che “La complessità contenutistica e strutturale del piano, dovuta alla compresenza di due distinti interessi ‒ quello connesso allo sviluppo del traffico marittimo e quello relativo alle finalità di carattere urbanistico ‒, non rende agevole la sua riconduzione nelle categorie in cui vengono usualmente classificati gli strumenti di pianificazione territoriale, facendone uno strumento di governo del territorio ‘atipico’, a metà strada tra un piano urbanistico speciale e un piano di settore”.
Tale impostazione è certamente condivisibile oltre che coerente con la ormai sempre più stringente capacità, in ambito portuale, di avere degli strumenti di programmazione, regolazione e pianificazione sempre più flessibili al fine di consentire una crescita e uno sviluppo dello scalo “al passo” con le nuove tecnologie e con la costante crescita dei traffici nonchè di tutte le attività economiche, industriali e commerciali.
Non è un caso, quindi, che la più recente giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel considerare i Piani regolatori portuali non assimilabili ad uno strumento urbanistico generale, seppur ben potrebbero essere considerati al pari di “Piani Strutturali”, proprio alla luce di quella flessibilità necessaria a consentire ai porti di poter trasformarsi a seconda delle esigenze infrastrutturali legate ai traffici ed alle attività dello stesso scalo marittimo.